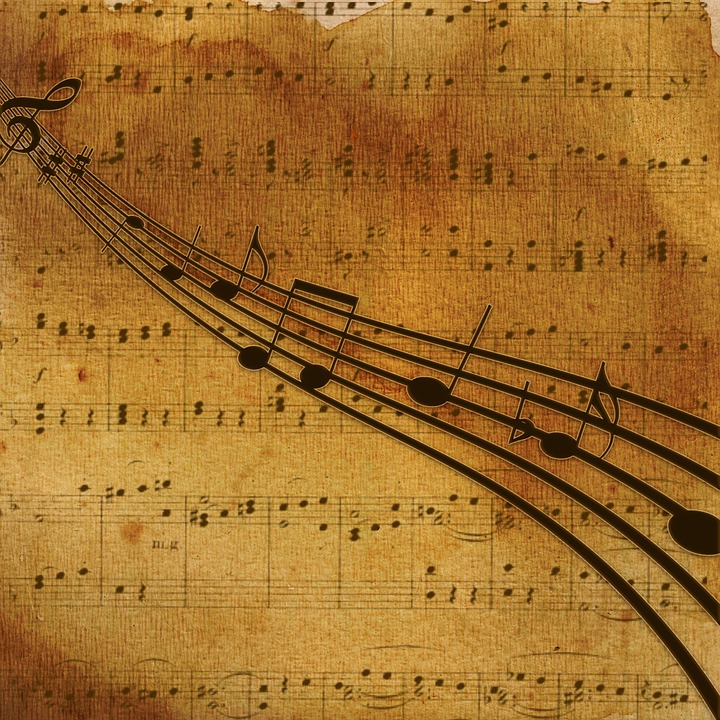Mio figlio Andrea ha la sindrome di Asperger. Ho passato tutta la mia vita a cercare risposte che non ho trovato. Perché proprio a lui? Perché proprio a me? E poi, ancora, perché no? Non è facile darsi risposte. Ma Andrea era lì, con i suoi occhi in attesa di vivere, di fare tutte le cose che i bambini e poi i ragazzi della sua età amano fare, solo con i suoi tempi, con i suoi modi. Il momento della diagnosi è stato quello più duro. Mio marito non ha retto. A volte gli uomini si fanno divorare dalla paura, dall’incertezza, dal sogno infranto di una vita perfetta. E così io e Andrea siamo rimasti soli. Con la nostre abitudini, con la nostra ricerca di una normalità che in certi momenti appariva lontanissima. Non era semplice capire cosa Andrea volesse davvero. Non era semplice fargli capire che doveva lavorare, lottare, impegnarsi come e più degli altri per ottenere cose che a chiunque altro sembravano scontate. Abbiamo passato anni a lottare contro insegnanti che pretendevano che Andrea imparasse a leggere e a scrivere fuori dalla classe, contro proprietari di giostre che volevano che un ragazzo di 17 anni salisse su un autoscontro con la sua mamma invece che con un amico; abbiamo lottato contro gli sguardi pietosi della gente, di quelle persone che prima rimanevano sorprese dalle qualità di Andrea e poi lasciavano che le loro labbra si incurvassero di finto dispiacere quando sentivano pronunciare il nome di quella sindrome che, a volte, sembrava scavalcare il nome stesso di mio figlio. Come quel giorno in cui Andrea sostenne l’esame di ammissione ad un corso musicale. Avevo chiesto al Preside della scuola di non dire nulla ai membri della commissione. Andrea voleva solo suonare e aveva bisogno di un insegnante che lo aiutasse a farlo. Non di educatori, psicologi, equipe mediche, di quelli ne avevamo già in abbondanza. Andrea voleva solo imparare a suonare. La musica non è una questione di apprendimento o di comportamento. La musica è musica. Il giorno in cui Andrea avesse smesso di lasciarsi incantare dalla magia della musica gli avrei fatto lasciare il corso. Ma, in quel momento, la musica rappresentava un tempo sospeso, uno spazio in cui, sia io che lui, vedevamo solo un ragazzo che suonava. Non una sindrome, non un obiettivo, non un’aspettativa. Vedevamo un ragazzo come tutti gli altri che faceva quello che amava. Andrea superò l’esame di ammissione a pieni voti. Quando poi i professori videro la diagnosi nella scheda di iscrizione, lessi nei loro occhi che avrebbero volentieri fatto marcia indietro. Ma ormai era stato ammesso. Al termine del corso Adrea vinse il primo premio per il miglior saggio di fine anno. Non che del premio ci importasse. Per Andrea non era stato importante il premio, era stata importante la gara. La possibilità di confrontarsi con ragazzi della sua età, di giocarsela alla pari con la vita. Quando Andrea finì le scuole superiori si aprì un baratro di fronte a noi. Mi venne proposto di inserire Andrea in un centro insieme ad altri ragazzi con varie disabilità. Non avevo nulla contro i centri, sapevo che la maggior parte di questi lavoravano in maniera eccellente. Ma sapevo che quella non era la risposta giusta per Andrea. Non in quel momento. Andrea aveva bisogno di continuare ad investire, a credere in qualcosa. A ritrovare intorno a sé una normalità, un obiettivo, una speranza. Avevo sentito parlare di un’associazione di genitori che si era costituita in un paese vicino a quello in cui abitavamo noi. Quei genitori avevano investito, con l’aiuto degli enti locali, in un’attività, un negozio, nel centro del piccolo paese. Vendevano prodotti a chilometro zero, comprati da produttori locali. Era un progetto più grande, che aveva come scopo quello di rilanciare l’economia a livello micro, per diffondere sul territorio il consumo di prodotti sani e non di importazione. Contemporaneamente, veniva data ad alcuni ragazzi con sindrome di Asperger la possibilità di vincere delle sfide un tempo per loro improponibili: il contatto con il pubblico, la relazione, l’autoimprenditorialità. Un giorno presi il coraggio a due mani e mi recai all’associazione e raccontai a quel signore, che aveva gli stessi miei occhi segnati dalla sofferenza, la storia di Andrea. Dopo tanti anni ho finalmente sentito che qualcuno poteva capirmi. Mi disse di accompagnare mio figlio al negozio il giorno successivo, per vedere che cosa si poteva fare. Andrea si dimostrò da subito entusiasta all’idea di rimanere con gli altri ragazzi qualche ora al giorno. Ormai io lo conoscevo. Aveva sempre bisogno di nuove sfide che gli facessero brillare gli occhi. Improvvisamente lo rividi bambino, mentre suonava il pianoforte il giorno della selezione per il corso musicale. Era il suo modo di sentirsi, di vivere, di sperare. Non è facile gestire un negozio. Servono metodo, precisione, ma anche collaborazione, intraprendenza, spirito di adattamento e capacità di affrontare anche qualche imprevisto. Per i ragazzi come Andrea a volte anche le cose semplici possono sembrare difficili. Mettere i prodotti in un ordine diverso da quello che lui aveva pensato, contrattare le forniture anche di prodotti che non sono di suo gradimento, rispondere ad un cliente che pone una domanda inattesa. Ma questi sono gli ostacoli che la sua vita deve affrontare. E lui questo lo sa. Adesso lui lo sa. Ma non sono le difficoltà ad essere importanti. Ciò che è importante è la possibilità di alzarsi ogni mattina con uno scopo, con un obiettivo da raggiungere, che ogni giorno sembra sempre meno lontano. E così adesso guardo Andrea: lo vedo scegliere i suoi vestiti, preparare la sua borsa con cura, chiudere la porta dietro di sé con il sorriso sulle labbra. Ascolto i suoi brevi racconti che mi parlano di un uomo cresciuto e più consapevole delle responsabilità che la vita comporta. Non vedo paura né preoccupazione, vedo entusiasmo e amore nei confronti di un sé che forse sta proprio adesso imparando a scoprire. Chissà se ha mai pensato di non farcela. Chissà se ha mai avuto un desiderio che non mi ha mai confessato. Chissà se in tutti questi anni sono stata abbastanza brava a nascondere la mia rabbia, la mia paura, la mia sofferenza, la mia preoccupazione. Ma oggi Andrea ride e questo mi basta. Accetta la sua vita così com’è. Una speciale normalità.
Monica Betti, docente del Master