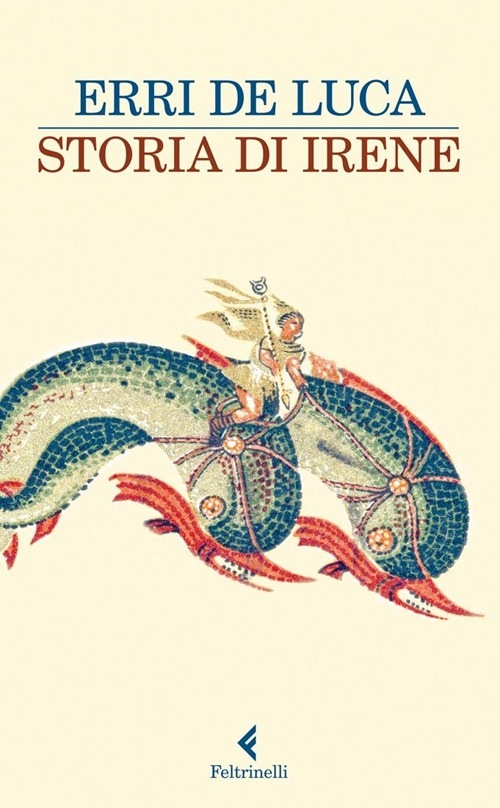Storia di Irene è un romanzo di Erri De Luca. Parla di Irene, unica superstite di un barcone pieno di clandestini che, salvata dai delfini, approda in un’isola greca degli anni settanta. Quando lo scrittore la incontra, Irene ha quattordici anni ed è incinta. Cresciuta con mezzi di fortuna, vivendo della carità di qualche pescatore e di qualche umile lavoro, si accinge a partorire un figlio che non ha cercato e del cui padre non vuole rivelare l’identità: non ha studiato, è analfabeta e l’unico linguaggio che conosce è quello dei delfini. L’unica legge che riconosce è quella del mare.
Elisa è stesa su un lettino in un reparto del Centro di Salute Mentale. Era scappata di casa la sera precedente ed aveva girovagato a vuoto in cerca di qualcuno che conoscesse e che potesse offrirgli una birra e un po’ di compagnia. La sua carta d’identità dice che ha quattordici anni, ma Elisa se ne sente molti di più, quelli che servono a portare sulle spalle tutto il male del mondo. Gli operatori che la accolgono le dicono che la nonna l’ha cercata per tutta la notte. Ma Elisa non ci crede, o comunque non le importa. In ogni caso di certo non l’ha cercata sua madre: non la vede da più di un anno, da quando ha preferito la compagnia dell’eroina alla sua. Sprofonda nel letto e si copre il viso con il lenzuolo. Non importa che l’abbiano cercata, la verità è che nessuno ha fatto niente per non farla andare via: né sua madre, che in questo momento sarà a casa dell’ennesimo compagno a farsi, né Andrea, che l’ha lasciata perché si era stancato della loro relazione che lo portava troppo lontano dagli amici, né sua nonna, che dice di volerle bene ma in realtà non vede l’ora di mandarla via di casa per non dover più rimediare a tutti i guai che combina. Gli infermieri le dicono che le devono fare le analisi del sangue e che la devono visitare. Bene. Così dalle analisi vedranno che ha fumato di nuovo. Come si era arrabbiata la nonna l’ultima volta. Pazienza. Le chiedono se ha avuto rapporti sessuali di recente. Certo, ha un ragazzo. Cioè, aveva un ragazzo. Consenzienti? Ovviamente, altrimenti lui diceva che non gli interessava stare con una suora. No, forse questo al dottore era meglio non dirlo. Ma chi se ne importa, ormai non le importa più di niente. Si gira di fianco, guarda fuori dalla finestra e si sforza di pensare ad un momento felice. Non ci riesce. No, aspetta. Forse quando è nato suo fratello. Sua madre e suo padre avevano detto che volevano riprovarci, che volevano stare insieme di nuovo. Poi era nato Costantino. Una felicità durata troppo poco. Perché sua madre non ce la faceva a stare dietro a quel bambino che piangeva giorno e notte e suo padre urlava che era un’incapace. Quando hanno festeggiato il primo compleanno di Costantino, con una crostatina al cioccolato del discount sulla quale Elisa aveva messo una delle vecchie candeline usate che la nonna conservava nella scatola di latta, suo padre se n’era già andato. A volte pensa che se Costantino non fosse mai nato forse tutto il resto non sarebbe successo. Ma non è vero. La sua famiglia non era felice nemmeno prima. Forse era proprio lei che non sarebbe dovuta nascere. Quindi è meglio che se ne vada. Maledetto quell’educatore, quello che le ha assegnato l’assistente sociale. È stato lui a trovarla alla stazione, mentre beveva una birra che le avevano offerto alcuni ragazzi che aveva conosciuto sul treno. Maledetta anche quell’assistente sociale che vuole sapere sempre quello che fa. Maledetta quella pedagogista che vuole che torni a scuola. Maledetti tutti, tutti quelli che fingono di volerle bene e di interessarsi a lei e che fanno delle cose solo per pulirsi la coscienza. Lo ricordo ancora il viso, smarrito e arrabbiato col mondo allo stesso tempo, che aveva Elisa. Irene era sopravvissuta alla rabbia delle onde che avevano ribaltato il barcone sul quale stava viaggiando in fuga dal suo Paese in guerra; Elisa era sopravvissuta alla rabbia di due genitori incapaci di prendersi cura di lei e di suo fratello. Entrambe sono sopravvissute fisicamente, ma dentro di loro hanno portato per tutta la vita i segni di quella povertà di cure, di amore, di risorse che le circondava. L’ombra di Irene è una zavorra, se la trascina dietro, in terra e sopra i muri. In mare no, se la toglie di dosso appena si infila nelle onde. Da quando è gravida non la salutano. È malasorte su un’isola il saluto levato. Non si ripara, o viaggi o muori. Il passato e il presente di Elisa sono una zavorra. Quando si sparge la voce della sua situazione familiare, del ricovero, del suo bisogno di cercare affetto e attenzioni come può, le sue coetanee la evitano. È così che una ragazzina di quattordici anni tocca la solitudine. E, come dice Irene, non si ripara, o viaggi o muori. E poiché non può viaggiare, Elisa comincia a morire dentro, giorno dopo giorno. Irene ha trovato una parziale salvezza nel conforto che il mare sa darle. Quel mare che le ha tolto tutto diviene in grado di darle riparo, conforto, l’amicizia dei delfini, che si rivela più solida e fedele di quella degli esseri umani. Elisa fissa il mondo con i suoi occhioni marroni sbarrati senza essere in grado di comprenderne il linguaggio. Come riesci ad saltare le onde, e hai pure quel peso in grembo, chiede lo scrittore ad Irene. La vita che ho dentro mi spinge a saltare. A terra mi pesa, in mare mi dà la rincorsa. Elisa non è mai riuscita a trovare un posto in cui il peso della sua zavorra, invece di affossarla, le desse la spinta per guardare più avanti, per andare più avanti. Ho fissato quegli occhi imploranti un aiuto che non sapeva come chiedere e ogni volta ho immaginato Elisa davanti allo stesso mare che abbracciava Irene, sperando con tutto il cuore che potesse trovare un luogo in cui essere accolta e amata. Quando la povertà educativa, che nel concreto si traduce in povertà economica, emotiva, relazionale sociale, avvolge la vita di minori innocenti e inconsapevoli rischia di produrre vuoti incolmabili. E non solo per l’assenza di opportunità. Elisa convive tuttora con la certezza di non essere amata. Combatte con la certezza di non essere amata. E cerca amore come può, da chi può. La prima cosa che mi hanno insegnato quando ho scelto questo lavoro è che bisogna allontanare da sé l’aspettativa di salvare le persone. A non cadere nella tentazione dell’onnipotenza salvifica non si impara solo studiando: è necessario un tempo lungo ed il coraggio di confrontarsi con la sofferenza umana. Ed anche se l’obiettivo del mio lavoro non è ad oggi quello di salvare nessuno, non posso nascondere che provo un forte desiderio di empatizzare con chi è vittima delle tante povertà che si abbattono come una mannaia sulla vita delle persone, soprattutto se queste sono minori. Tutti coloro che ho conosciuto nel mio lavoro, prima di essere casi, hanno rappresentato storie da incontrare, dalle quali lasciarsi attraversare non solo per assolvere al proprio compito nel migliore dei modi, ma anche per crescere a livello umano. Dalle storie di quelle persone ho ricevuto molto più di qualsiasi cosa abbia potuto dare. Il mondo è pieno di ingiustizia ed iniquità e non servono dati statistici per rilevarlo. Lo vediamo intorno a noi ogni giorno ed ogni giorno sperimentiamo cosa significhi essere nati nella parte del mondo che conta, nella regione con più possibilità, nella famiglia giusta. L’avere avuto tutto questo non costituisce alcun merito. Né dobbiamo mai dimenticare di considerare cosa ne sarebbe stato di noi se così non fosse stato. Io me lo chiedo ogni giorno. Me lo chiedo ogni volta che due occhi colmi pieni di tutta la sofferenza del mondo, come quelli di Elisa, incontrano i miei. Credo che il mio lavoro mi abbia insegnato che partire da questa domanda sia fondamentale per cercare di contrastare le povertà educative che rischiano di segnare per sempre la vita dei minori di cui siamo chiamati a prenderci cura.