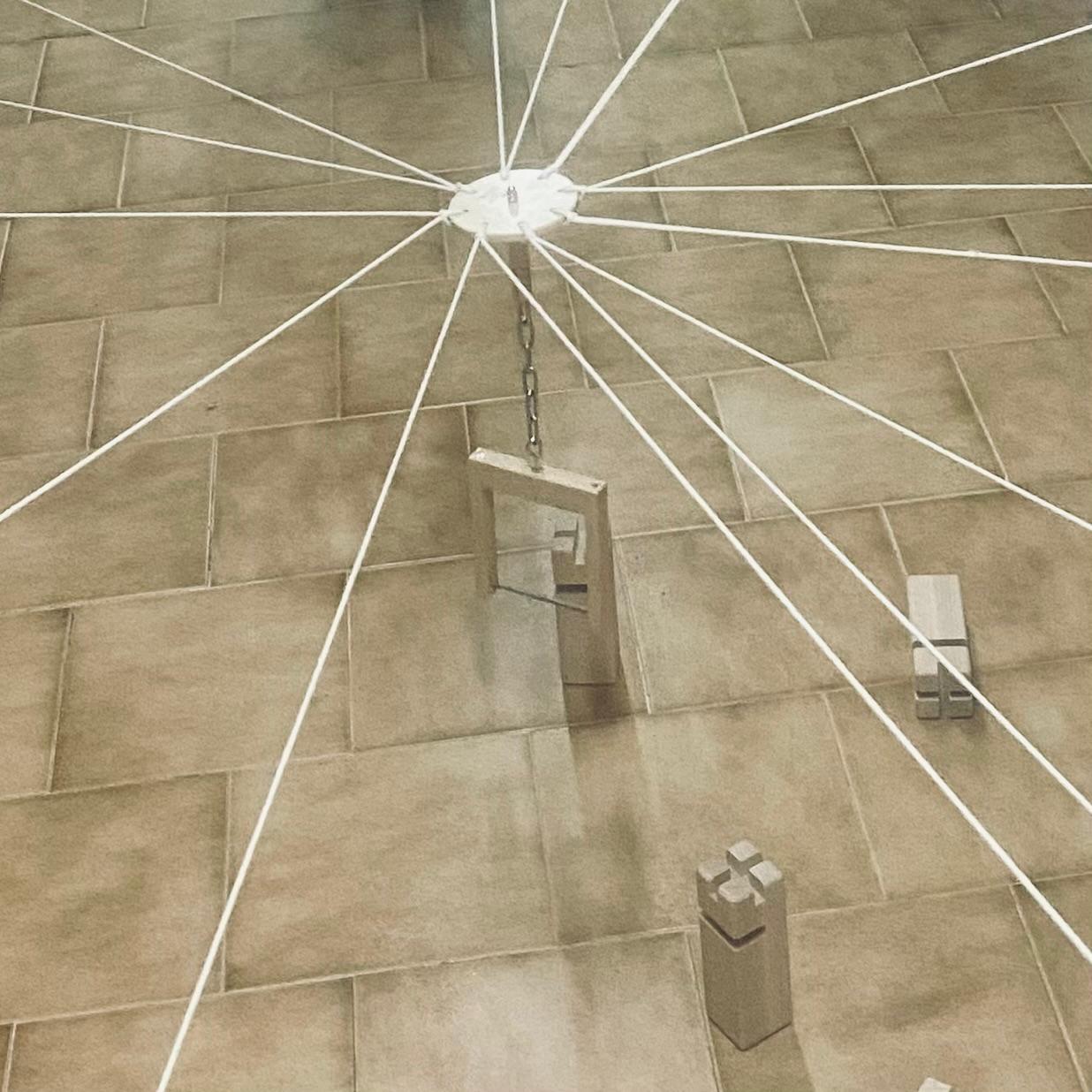A luglio dell’anno scorso 3 minorenni (di 7 indagati) e 2 (appena) maggiorenni venivano condannati per gli stupri di Caivano che avevano aperto uno squarcio nella nostra coscienza sull’orrendo abisso di degrado in cui infanzia e adolescenza possono sprofondare. Un abisso così agghiacciante da fermare il nostro orrore sull’età delle vittime e sul degrado sociale e criminale del contesto, senza cogliere appieno la cultura dello stupro che aveva guidato i giovanissimi carnefici. Qualcosa però, sotto il suono incessante dell’allarme femminicidi, probabilmente si muove. E intorno all’omicidio premeditato di Giulia Cecchettin, per cui ieri l’ex-fidanzato 22enne ha avuto l’ergastolo, il generico discorso sul femminicidio sta evolvendo in un dibattito pubblico sul patriarcato (finalmente, ma anche grazie alla straordinaria reazione della sua famiglia). Sebbene il patriarcato come istituzione sia superato, e il ministro lo consideri morto e sepolto, esso continua a mietere vittime, e come struttura di potere “vive e lotta contro di noi” (cit. Fabrizia Giuliani). E la cultura dello stupro non è che la descrizione di come tale struttura di potere, anche quando le leggi la vorrebbero superata, si traduca in pensiero e azione, in una barbarica “legge del desiderio” che naturalizza, giustifica e premia il diritto del maschio a predare e stuprare. Se una critica dovessi muovere alla scelta del termine “patriarcato” sarebbe se mai che mi sembra parziale. Si concentra sulle dinamiche di potere dell’eteronormatività, evidenziandone solo l’aspetto del dominio maschile e della subordinazione/oggettificazione della donna, alludendo solo implicitamente ad altri aspetti come il sessismo benevolo e paternalista, l’omolesbobitransfobia e il pronatalismo. Allo stesso tempo, in un momento in cui il dibattito sul genere è avvelenato da voluti fraintendimenti, il recupero di questa parola sembra utile a rinfrescare le idee, e il focus sulle strutture di potere risulta fondamentale.
Vorrei compiere un’operazione per me insolita, vorrei guardare ad alcuni aspetti di questa vicenda lasciando il tema del genere sullo sfondo (pur tenendo a mente che è nella gerarchia di genere che essi si realizzano). Voglio provare a fare questo per mettere a fuoco alcuni processi che offrono la struttura emotiva su cui la cultura dello stupro attecchisce tra l3 nostr3 adolescenti. Anche perché, per quanto storicamente sia il maschile ad essere costruito così, nella decostruzione sociale del genere attualmente in atto, questi elementi potrebbero facilmente trapiantarsi a qualunque soggettività. Si tratta forse di ribadire l’ovvio: che le persone diventano più facilmente violente in una società ingiusta e in cui la giustizia è guardata come un fatto individuale.
Quando parliamo di violenza relazionale, parliamo di un danno inflitto deliberatamente per mantenere, contrastare o capovolgere una relazione di potere. A seconda del danno preso in considerazione, potremo cogliere diversi tipi di violenza, ma la giustizia si muove di solito quando il danno è macroscopico. Se il potere è pari o alternato abbiamo un conflitto violento, se è sbilanciato dalla parte del perpetratore della violenza è una forma di abuso (notiamo en passant che dentro strutture di potere patriarcali, un maschile costruito come violento è sistematicamente conflittuale con l’altro maschile e abusante con il femminile…). Se la giustizia riparativa cerca un cambiamento nelle premesse di potere che hanno generato la violenza, la giustizia retributiva impone che chi commette abuso sia privatə della sua facoltà di nuocere, spogliatə di quei privilegi e di quel potere che gli hanno permesso di offendere (ruolo sociale, libertà, etc). Non entrerò qui nel merito di questo dibattito, ma anche stando sul piano della giustizia retributiva, si tratta di un piano sociale che va distinto dall’offrire retribuzione alla rabbia che naturalmente emerge come risposta al danno e alla minaccia, generando la reazione violenta alla violenza. Quando slittiamo sul piano individuale e soggettivo, perdiamo la distinzione tra la ricerca collettiva di giustizia e la reazione rabbiosa individuale, facendo saltare uno dei nodi fondamentali del nostro tessuto sociale. Il risultato è che ogni soggetto può, dal suo punto di vista, viversi come vittima delle circostanze. Il potere non è mai unilaterale, come ricorda Foucault, ma è l’emergere nel contesto di una certa possibilità di azione, e quando parliamo di possibilità di azione, la percezione delle proprie possibilità (o mancanza di questa) ha un impatto concreto sulle proprie effettive possibilità. Ma la narrazione del potere unilaterale (come ricorda Bateson) è un mito che corrompe le relazioni ponendo le persone nella ricerca del potere come strumento per non subirlo (e, notiamo en passant anche qui, l’ideologia patriarcale è fondata su questo mito). Ogni individuo quando ha paura, quando le cose sfuggono al suo controllo, può viversi come impotente, come punto di ricaduta delle forze universali che ne impediscono le possibilità di essere felice e, in questa posizione vittimaria, può cercare un nemico cui attribuire vittimisticamente la responsabilità di non averlə salvatə (cit. Paolo Rigliano). È questo, sembra, che ha fatto Filippo Turetta identificando in Giulia la depositaria di una salvezza (colei che lo rassicurava nel suo valore) che lo abbandonava e che meritava per questo, ai suoi occhi, di essere punita. Ed è ciò che fa ogni maschio femminicida che nell’arena torrida del patriarcato si è sentito protetto dal suo ruolo di padre di famiglia e all’improvviso se ne vede privato da una moglie stufa delle sue pretese. In un contesto, poi, di generale impotenza (come può essere stata in senso estremo Caivano, ma anche come può essere vissuto il presente per la generazione z e presto per quelle alfa), il mito del potere può sembrare l’unica possibilità di emergere, rinforzando l’idea di un gioco le cui regole sono di dominare o essere dominati (e, en passant, questo per Bourdieu è l’habitus maschile). E in un gioco simile, sentire di perdere il proprio dominio può coincidere con il sentirsi sopraffatt3 e dominat3 dall’altrə. Un circolo vizioso: in un mondo di homo homini lupus, l’esibizione tossica del potere (lo faccio perché posso farlo) può sembrare un modo di non farsi sbranare… e perfino di non far sbranare l’altrə (versione giustiziere).
Unə adolescente iniziatə a questa logica è un cucciolo spaventato condannato a trasformarsi in una belva. Credo che rispetto a questo dobbiamo chiederci dove stia l’innesco, e in che momento unə giovane (uomo di solito, ma chiunque) divenga “vittima del mondo”, finendo per sentire che l’unica reazione possibile è l’attacco dell’altrə, come strumento per ristabilire il proprio valore e la propria possibilità di esistere. La risposta semplice sta oltre il dolore e il trauma, sta nella perdita del legame: nel vivere il proprio dolore nell’impotenza e nella solitudine…
Ma questo risponde anche alla domanda su cosa si può fare: la cura sociale del legame e la moltiplicazione dei legami, che permettano anche il lutto di alcuni legami (qualcunə in questa Università di Ferrara ha detto: da soli mai). Una cultura del legame che implichi la responsabilità dell3 singol3, quando infliggono, quando subiscono danno, e quando lo vedono inflitto, di stare nel legame, di riparare il legame, senza negare, né cancellare, e nemmeno giustificare o colludere, ma sempre chiedendo conto, in un processo di confronto e accompagnamento, se possibile di dialogo.
Che, a ben vedere, non è diverso dalla lotta al patriarcato.
Federico Ferrari, psicologo psicoterapeuta, terapeuta di coppia e familiare