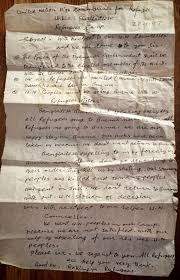Al campo mi chiamano “il bambino con la matita”. Me l’ha regalata la signora che viene ogni tanto a trovare i bambini delle baracche per insegnargli a leggere e a scrivere. Desideravo tanto una matita. Appena l’ho avuta in mano ho cominciato a disegnare la mia casa, quella in Rakhine.
Mio padre dice che un giorno ci torneremo, ma non so se sia vero. Così io l’ho disegnata. E poi, vicino, ho disegnato anche la mamma, i nonni, la mia sorella più grande, che oggi ha diciotto anni, e mia zia. Loro sono rimasti tutti in Rakhine. Li ho voluti disegnare perché il giorno della Grande Paura non ho avuto nemmeno il tempo di portare con me una fotografia, né la scatola di colori che mi avevano regalato per il compleanno. Li disegno perché ho paura di dimenticarli. Un giorno ho chiesto a mio padre se quando torneremo nella nostra casa troveremo anche loro, ma mio padre non ha risposto. Allora una delle signore che vive con noi nella baracca mi ha detto che devo ricordare quelli che non sono potuti venire con noi nella mia mente e che non devo pensare più alla mia vita in Rakhine. Non che la mia vita di prima mi manchi molto, a dire la verità. Almeno la vita che mi ricordo. Non potevo andare a giocare con gli altri bambini, o uscire con i miei genitori per strada o nella piazza. E durante il coprifuoco dovevamo stare attenti a non uscire e a non farci sentire. La mattina dopo venivamo sempre a sapere qualcosa che preoccupava molto i miei genitori: una volta venne di corsa una donna piangendo e chiedendo ai miei genitori aiuto perché i soldati avevano fatto del male a sua figlia e avevano sparato a suo marito che aveva cercato di difenderla. Poi avevano portato via la ragazza e lei non ne aveva saputo più niente. Quando chiesi a mio padre perché i soldati avessero fatto tanto male al marito e alla figlia della signora Sofaer, lui mi disse che era successo perché siamo Rahingya, musulmani: preghiamo Allah, abbiamo tradizioni diverse dai cittadini birmani. E alla gente non piacciono le cose diverse. Non mi manca la mia vita di prima: non potevo andare tutti i giorni a scuola e ogni giorno succedevano cose brutte che facevano piangere tanto la mia mamma e mia sorella. Non mi manca la mia vita di prima, ma la mia casa, la mamma, mia sorella, i nonni e la zia mi mancano tanto. Prima della Grande Paura venivano spesso a trovarci. Recitavamo le preghiere, mostravo loro le cose che facevo a scuola; non era una vera e propria scuola, era una capanna dove una signora istruita ci insegnava a leggere e a scrivere. Non potevamo andarci tutti i giorni, ma ero molto contento quando potevo farlo. Per il mio settimo compleanno, l’ultimo in Rakhine, mi avevano regalato una scatola di colori perché a me piace molto disegnare. La mamma mi diceva che un giorno sarei diventato un grande artista e che persone da tutto il mondo sarebbero venute in Birmania per vedere i miei capolavori. Poi i nonni e la zia sono tornati a casa, prima che iniziasse il coprifuoco. Non sono tornati più. La mamma ha pianto tanto, diceva che era colpa dei soldati se non sarebbero più venuti. E poi ha detto a mio padre che dovevamo andarcene via, che era inutile rimanere qui a farsi ammazzare. Ma mio padre non voleva lasciare la nostra casa perché diceva che anche noi eravamo cittadini birmani e che avevamo il diritto di restare lì. Io non lo so che cosa significhi essere birmano, o musulmano, o bengalese, come dicono con disprezzo i soldati. Io sono un bambino: mi guardo intorno e vedo tanti altri bambini come me. A me non importa se gli altri bambini o i loro genitori pregano Allah, o un altro dio, o non pregano affatto. Io faccio quello che mi hanno insegnato e penso che ciascuno debba fare quello che gli hanno insegnato i suoi genitori. Che male ci può essere in questo? Se avessi potuto continuare ad andare a scuola certamente avrei imparato a disegnare molto bene. Uno dei bambini che vive nella baracca con me dice che avrebbe voluto fare il medico. Ma a noi Rohingya è proibito andare a scuola. Ogni tanto vengono delle persone che sembrano molto buone e gentili, come la signora che mi ha regalato la matita, ci danno qualche colore e un po’ di carta e ci chiedono se sappiamo leggere e scrivere. Io avevo imparato a scrivere qualche parola, ma dopo la Grande Paura mi sono un po’ dimenticato. È bello quando quei signori, volontari li chiamano, vengono a farci giocare e ci leggono delle storie. Per un po’ mi dimentico della baracca in cui vivo adesso, non penso alla coperta che mio padre ha steso per terra e in cui dormiamo, perché non c’è posto per tutti; non penso alla fame, non penso a quel giorno in cui ho fatto una corsa con Khali, il mio amico che abitava vicino a me in Rakhine, e abbiamo riso come matti perché pensavamo che ci rincorresse una tigre alata. Il giorno della Grande Paura io, la mamma, mio padre e mia sorella siamo scappati di casa. I soldati ci inseguivano. Sentivamo gli spari da ogni parte. Mi sono tappato le orecchie e mio padre mi ha preso in braccio e abbiamo cominciato a correre. Quando siamo arrivati alla riva del fiume mia madre e mia sorella non c’erano più. Ho chiesto mille volte a mio padre perché non sono salite sulla zattera con noi e per mille volte lui non ha risposto. A volte penso che i soldati le abbiano prese, che gli spari le abbiano raggiunte, penso che siano morte. Ma questo pensiero mi fa sentire un dolore talmente grande all’altezza del petto che preferisco pensare che invece abbiano provato a tornare a casa. Mi sembrava di ricordare che i soldati le avessero dato fuoco, ma forse non è vero, mi ricordo male. Forse sono tornate a casa e ci aspettano lì. Forse la mamma ha ritrovato i miei disegni e ha riordinato la scatola dei colori. Chiudo gli occhi e immagino un tempo prima della paura, un tempo che non ricordo nemmeno più. Immaginare di non avere più paura, di poter giocare e di poter disegnare mi fa sentire un po’ meno triste. E anche il cattivo odore della baracca e la sporcizia mi sembrano meno brutte. E quando mi torna la paura e non riesco a trattenere le lacrime chiudo gli occhi e penso all’abbraccio di mia madre. In qualche modo, mi sembra di sentire che mi stia abbracciando anche lei. Questa è una delle tante storie che si potrebbero ascoltare nei campi profughi in Bangladesh che accolgono, dalla fine di agosto 2017, i Rohingya, un gruppo di fede musulmana in fuga dallo Stato di Rakhine, in Myanmar. I Rohingya sono una popolazione poverissima, i quali non vengono riconosciuti come cittadini birmani, in quanto ritenuti bengalesi musulmani arrivati con la colonizzazione britannica. La loro vita in Rakhine era divenuta insostenibile, poichè i rapporti, da sempre tesi con la popolazione birmana e con le milizie, sono nel 2017 sfociati in episodi di violenza senza confine. Pertanto, alla fine di agosto, i Rohingya sono fuggiti in Bangladesh, affrontando un viaggio peno di pericoli che ha portato molti di loro alla morte. I sopravvissuti hanno raccontato violenze incredibili, dei veri e propri crimini contro l’umanità, inflitti senza pietà a uomini, donne e bambini di qualsiasi età. Ad oggi la situazione non è certo migliore: il governo di Dakha lamenta il peso della gestione di migliaia di profughi e richiama le autorità birmane a farsi carico di una popolazione di cui hanno la piena responsabilità. Ma i Rohingya non accettano, volontariamente, il rimpatrio: non senza l’acquisizione della cittadinanza birmana, che garantirebbe loro un’esistenza, anche se povera, almeno in condizioni di pace. La storia di questa popolazione ci ricorda che esistono altre storie di sofferenza, di migrazione, di povertà e di violenza a questo mondo. Lontano da quello che crediamo essere la nostra priorità, lontano da quello che scegliamo di vedere. Crediamo lontano anche il tempo in cui una popolazione veniva discriminata per la loro storia, per la loro religione. Crediamo che tutto questo appartenga al passato. E invece il passato si avvelena di presente. Più della metà delle persone stipate nei campi profughi in Bangladesh sono bambini. Non hanno niente: né cibo, né coperte, né acqua potabile, per non parlare di giochi, libri e quaderni. Muoiono a centinaia e, molto spesso, non c’è rimasto nemmeno nessuno a piangerne la morte. Sono solo bambini e hanno già conosciuto il male del mondo. Le associazioni umanitarie si fanno carico di portare loro l’indispensabile, ma è una goccia nel mare, se paragonato ai loro bisogni ed alle loro insanabili sofferenze. Non so dire se un giorno qualcuno chiederà conto dei crimini commessi contro esseri umani, a prescindere dalla loro storia, provenienza, religione. Non so se sapremo riempirci il cuore di sdegno e umana vergogna per aver finto di non aver visto e sentito, o se piegheremo la testa dall’altra parte come abbiamo sempre fatto. Non so se, a parte lo sdegno e la vergogna, potremo almeno aprire la nostra mente alla compassione, quel sentimento che permetterebbe di sentirci responsabili gli uni degli altri in una comunità umana. Non so se sapremo rinunciare ad una sola delle nostre abitudini individualiste e consumiste per donare un po’ del nostro superfluo a chi ne ha un bisogno disperato. Ma so che, leggendo i rapporti di Save the Children, ho immaginato la storia che ho scritto. Ho immaginato me, mio marito e mio figlio in fuga verso un posto sconosciuto, rischiando la vita ogni minuto. Ho immaginato solo per un istante che potessero strapparmi dalle braccia mio figlio e quell’istante è stato sufficiente per decidere di pensare ad altro, perché il dolore che ho provato ad immaginare una cosa improbabile è stato talmente forte da non potermi capacitare di come altre donne come me abbiano potuto affrontare, nella realtà, il peggiore di tutti i dolori. Per non parlare poi della violenza e della morte di tutti coloro che si amano. Non so se la consapevolezza dell’esistenza di tutto questo sarà sufficiente a scuotere, una volta per tutte, la coscienza di chi si sente al riparo dal pericolo di una vita che non gli è toccata. Ma so che non possiamo consegnare all’oblio l’umana sofferenza che emerge dalle storie di discriminazione e violenza che esistono in ogni parte del mondo.